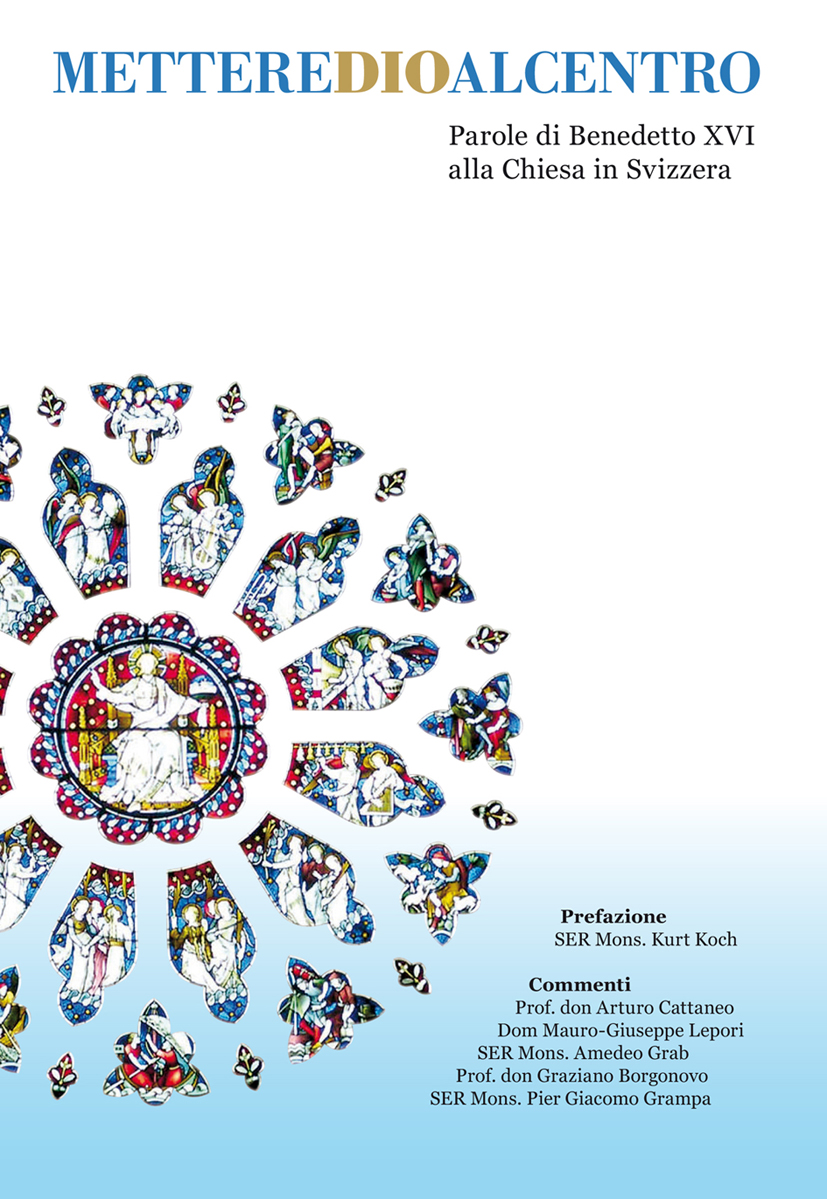L'omelia
Cari confratelli,
i testi appena ascoltati – la Lettura, il Salmo responsoriale
e il Vangelo – hanno un tema comune che potrebbe essere riassunto
nella frase: Dio non fallisce. O più esattamente: inizialmente Dio
fallisce sempre, lascia esistere la libertà dell’uomo, e questa dice
continuamente «no». Ma la fantasia di Dio, la forza creatrice del
suo amore è più grande del «no» umano. Con ogni «no» umano viene
dispensata una nuova dimensione del suo amore, ed Egli trova una
via nuova, più grande, per realizzare il suo sì all’uomo, alla sua
storia e alla creazione. Nel grande inno a Cristo della Lettera ai
Filippesi con cui abbiamo iniziato, ascoltiamo innanzitutto un’allusione
alla storia di Adamo, il quale non era soddisfatto dell’amicizia
con Dio; era troppo poco per lui, volendo essere lui stesso un dio.
Considerò l’amicizia una dipendenza e si ritenne un dio, come se
egli potesse esistere da sé soltanto. Perciò disse «no» per diventare
egli stesso un dio, e proprio in tal modo si buttò giù lui stesso
dalla sua altezza. Dio «fallisce» in Adamo – e così apparentemente
nel corso di tutta la storia. Ma Dio non fallisce, poiché ora diventa
lui stesso uomo e ricomincia così una nuova umanità; radica l’essere
Dio nell’essere uomo in modo irrevocabile e scende fino agli abissi
più profondi dell’essere uomo; si abbassa fino alla croce. Vince
la superbia con l’umiltà e con l’obbedienza della croce.
E così ora avviene ciò che Isaia, cap. 45, aveva profetizzato.
All’epoca in cui Israele era in esilio ed era scomparso dalla cartina
geografica, il profeta aveva predetto che il mondo intero – «ogni
ginocchio» – si sarebbe piegato dinanzi a questo Dio impotente.
E la Lettera ai Filippesi lo conferma: Ora ciò è accaduto. Per mezzo
della croce di Cristo, Dio si è avvicinato alle genti, è uscito da
Israele ed è diventato il Dio del mondo. E ora il cosmo piega le
ginocchia dinanzi a Gesù Cristo, cosa che anche noi oggi possiamo
sperimentare in modo meraviglioso: in tutti i continenti, fino alle
più umili capanne, il Crocifisso è presente. Il Dio che aveva «fallito»,
ora, attraverso il suo amore, porta davvero l’uomo a piegare le ginocchia,
e così vince il mondo con il suo amore.
Come Salmo responsoriale abbiamo cantato la seconda parte del Salmo
della passione 21/22. È il Salmo del giusto sofferente, prima di
tutto di Israele sofferente che, dinanzi al Dio muto che lo ha abbandonato,
grida: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come hai potuto
dimenticarmi? Ora quasi non ci sono più. Tu non agisci più, non parli
più… Perché mi hai abbandonato?». Gesù si identifica con l’Israele
sofferente, con i giusti sofferenti di ogni tempo abbandonati da
Dio, e porta il grido dell’abbandono di Dio, la sofferenza dell’essere
dimenticato lo porta su fino al cuore di Dio stesso, e trasforma
così il mondo. La seconda parte del Salmo, quella che abbiamo recitato,
ci dice che cosa ne deriva: I poveri mangeranno e saranno saziati.
È l’eucaristia universale che proviene dalla croce. Ora Dio sazia
gli uomini in tutto il mondo, i poveri che hanno bisogno di lui.
Egli dà loro la sazietà di cui hanno bisogno: dona Dio, dona se stesso.
E poi il Salmo dice: «Torneranno al Signore tutti i confini della
terra». Dalla croce deriva la Chiesa universale. Dio va oltre l’ebraismo
e abbraccia il mondo intero per unirlo nel banchetto dei poveri.
E, infine, il messaggio del Vangelo. Di nuovo il fallimento di Dio.
Coloro che sono stati invitati per primi disdicono, non vengono.
La sala di Dio rimane vuota, il banchetto sembra essere stato preparato
invano. È ciò che Gesù sperimenta nella fase finale della sua attività:
i gruppi ufficiali, autorevoli dicono «no» all’invito di Dio, che
è Lui stesso. Non vengono. Il suo messaggio, la sua chiamata finisce
nel «no» degli uomini. E però anche qui: Dio non fallisce. La sala
vuota diventa un’opportunità per chiamare un maggior numero di persone.
L’amore di Dio, l’invito di Dio si allarga – Luca ci racconta questo
in due ondate: Prima, l’invito è rivolto ai poveri, agli abbandonati,
a quelli non invitati da nessuno nella stessa città. In tal modo
Dio fa ciò che abbiamo sentito nel Vangelo ieri. (Il Vangelo di oggi
fa parte di un piccolo simposio nel quadro di una cena presso un
fariseo. Troviamo quattro testi: prima la guarigione dell’idropico,
poi la parola sugli ultimi posti, poi l’insegnamento di non invitare
gli amici i quali contraccambierebbero tale gesto, ma coloro che
hanno davvero fame, i quali, però, non possono contraccambiare l’invito,
e poi, appunto, segue il nostro racconto). Dio ora fa ciò che ha
detto al fariseo: Egli invita coloro che non possiedono nulla; che
hanno davvero fame, che non possono invitarlo, che non possono dargli
nulla. E poi avviene la secondo ondata. Esce fuori dalla città, nelle
strade di campagna; sono invitati i senza dimora.
Possiamo supporre che Luca abbia inteso queste due ondate nel senso
che primi ad entrare nella sala sono i poveri d’Israele e dopo – poiché
non sono sufficienti, essendo l’ambiente di Dio più grande –
l’invito si estende al di fuori della Città Santa verso il mondo
delle genti. Coloro che non appartengono affatto a Dio, che stanno
fuori, vengono ora invitati per riempire la sala. E Luca che ci ha
tramandato questo Vangelo, in ciò ha visto sicuramente la rappresentazione
anticipata in modo immaginifico degli avvenimenti che poi narra negli
Atti degli Apostoli, dove proprio ciò accade: Paolo inizia la sua
missione sempre nella sinagoga, da quanti sono stati invitati per
primi, e solo quando le persone autorevoli hanno disdetto ed è rimasto
soltanto un piccolo gruppo di poveri, egli esce fuori verso i pagani.
Così il Vangelo, attraverso questo percorso di crocifissione sempre
nuovo, diventa universale, afferra il tutto, finalmente fino a Roma.
A Roma Paolo chiama a sé i capi della sinagoga, annuncia loro il
mistero di Gesù Cristo, il Regno di Dio nella persona di Lui. Ma
le parti autorevoli disdicono, ed egli si congeda da loro con queste
parole: Ebbene, poiché non ascoltate, questo messaggio viene annunziato
ai pagani ed essi l’ascolteranno. Con tale fiducia si conclude il
messaggio del fallimento: Essi ascolteranno; la Chiesa dei pagani
si formerà. E si è formata e continua a formarsi. Durante le Visite ad
limina sento parlare di molte cose gravi e faticose, ma sempre
– proprio dal Terzo Mondo – sento anche questo: che gli
uomini ascoltano, che essi vengono, che anch’oggi il messaggio giunge
per le strade fino ai confini della terra e che gli uomini affluiscono
nella sala di Dio, al suo banchetto.
Dovremmo quindi domandarci: Che cosa tutto ciò significa per
noi? Innanzitutto significa una certezza: Dio non fallisce. «Fallisce»
continuamente, ma proprio per questo non fallisce, perché ne trae
nuove opportunità di misericordia più grande, e la sua fantasia è
inesauribile. Non fallisce perché trova sempre nuovi modi per raggiungere
gli uomini e per aprire di più la sua grande casa, affinché si riempia
del tutto. Non fallisce perché non si sottrae alla prospettiva di
sollecitare gli uomini perché vengano a sedersi alla sua mensa, a
prendere il cibo dei poveri, nel quale viene offerto il dono prezioso,
Dio stesso. Dio non fallisce, nemmeno oggi. Anche se sperimentiamo
tanti «no», possiamo esserne certi. Da tutta questa storia di Dio,
a partire da Adamo, possiamo concludere: Egli non fallisce. Anche
oggi troverà nuove vie per chiamare gli uomini e vuole avere con
sé noi come suoi messaggeri e suoi servitori.
Proprio nel nostro tempo conosciamo molto bene il «dire no» di quanti
sono stati invitati per primi. In effetti, la cristianità occidentale,
cioè i nuovi «primi invitati», ora in gran parte disdicono, non hanno
tempo per venire dal Signore. Conosciamo le chiese che diventano
sempre più vuote, i seminari che continuano a svuotarsi, le case
religiose che sono sempre più vuote; conosciamo tutte le forme nelle
quali si presenta questo «no, ho altre cose importanti da fare».
E ci spaventa e ci sconvolge l’essere testimoni di questo scusarsi
e disdire dei primi invitati, che in realtà dovrebbero conoscere
la grandezza dell’invito e dovrebbero sentirsi spinti da quella parte.
Che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo porci la domanda: perché
accade proprio così? Nella sua parabola il Signore cita due motivi:
il possesso e i rapporti umani, che coinvolgono talmente le persone
che esse ritengono di non avere più bisogno di altro per riempire
totalmente il loro tempo e quindi la loro esistenza interiore. San
Gregorio Magno nella sua esposizione di questo testo ha cercato di
andare più a fondo e si è domandato: ma com’è possibile che un uomo
dica «no» a ciò che vi è di più grande; che non abbia tempo per ciò
che è più importante; che chiuda in se stesso la propria esistenza?
E risponde: In realtà, non hanno mai fatto l’esperienza di Dio; non
hanno mai preso «gusto» di Dio; non hanno mai sperimentato quanto
sia delizioso essere «toccati» da Dio! Manca loro questo «contatto»
– e con ciò il «gusto di Dio». E solo se noi, per così dire, lo gustiamo,
solo allora veniamo al banchetto.
San Gregorio cita il Salmo, dal quale è tratta l’odierna Antifona
alla Comunione: Gustate ed assaggiate e vedete; assaggiate ed allora
vedrete e sarete illuminati! Il nostro compito è di aiutare affinché
le persone possano assaggiare, affinché possano sentire di nuovo
il gusto di Dio. In un’altra omelia san Gregorio Magno ha ulteriormente
approfondito la stessa questione, e si è domandato: Come mai avviene
che l’uomo non vuole nemmeno «assaggiare» Dio? E risponde: Quando
l’uomo è occupato interamente col suo mondo, con le cose materiali,
con ciò che può fare, con tutto ciò che è fattibile e che gli porta
successo, con tutto ciò che può produrre o comprendere da se stesso,
allora la sua capacità di percezione nei confronti di Dio s’indebolisce,
l’organo volto a Dio deperisce, diventa incapace di percepire ed
insensibile. Egli non percepisce più il Divino, perché il corrispondente
organo in lui si è inaridito, non si è più sviluppato. Quando utilizza
troppo tutti gli altri organi, quelli empirici, allora può accadere
che proprio il senso di Dio si appiattisca; che questo organo muoia;
e che l’uomo, come dice san Gregorio, non percepisca più lo sguardo
di Dio, l’essere guardato da Lui – questa cosa preziosa che è il
fatto che il suo sguardo mi tocchi!
Ritengo che san Gregorio Magno abbia descritto esattamente la situazione
del nostro tempo – in effetti, era un’epoca molto simile alla nostra.
E ancora sorge la domanda: che cosa dobbiamo fare? Ritengo che la
prima cosa sia quella che il Signore ci dice oggi nella Prima Lettura
e che san Paolo grida a noi a nome di Dio: «Abbiate gli stessi sentimenti
di Gesù Cristo! – Touto phroneite en hymin ho kai en Christo
Iesou». Imparate a pensare come ha pensato Cristo, imparate
a pensare con Lui! E questo pensare non è solo quello dell’intelletto,
ma anche un pensare del cuore. Noi impariamo i sentimenti di Gesù
Cristo quando impariamo a pensare con Lui e quindi, quando impariamo
a pensare anche al suo fallimento e al suo attraversare il fallimento,
l’accrescersi del suo amore nel fallimento. Se entriamo in questi
suoi sentimenti, se incominciamo ad esercitarci a pensare come Lui
e con Lui, allora si risveglia in noi la gioia verso Dio, la fiducia
che Egli è comunque il più forte; sì, possiamo dire, si risveglia
in noi l’amore per Lui. Sentiamo quanto è bello che Egli c’è e che
possiamo conoscerLo – che lo conosciamo nel volto di Gesù Cristo,
che ha sofferto per noi. Penso che sia questa la prima cosa: che
noi stessi entriamo in un contatto vivo con Dio – con il Signore
Gesù, il Dio vivente; che in noi si rafforzi l’organo volto a Dio;
che portiamo in noi stessi la percezione della sua «squisitezza».
Ciò dà anima anche al nostro operare; poiché anche noi corriamo un
pericolo: Si può fare molto, tanto nel campo ecclesiastico, tutto
per Dio…, e in ciò rimanere totalmente presso sé stessi, senza incontrare
Dio. L’impegno sostituisce la fede, ma poi si vuota dall’interno.
Ritengo, pertanto, che dovremmo impegnarci soprattutto: nell’ascolto
del Signore, nella preghiera, nella partecipazione intima ai sacramenti,
nell’imparare i sentimenti di Dio nel volto e nelle sofferenze degli
uomini, per essere così contagiati dalla sua gioia, dal suo zelo,
dal suo amore e per guardare con Lui, e partendo da Lui, il mondo.
Se riusciamo a fare questo, allora anche in mezzo a tanti «no» troviamo
di nuovo gli uomini che Lo attendono e che spesso forse sono bizzarri
– la parabola lo dice chiaramente – ma che comunque sono
chiamati ad entrare nella sua sala.
Ancora una volta, con altre parole: Si tratta della centralità di
Dio, e precisamente non di un dio qualunque, bensì del Dio che ha
il volto di Gesù Cristo. Questo, oggi, è importante. Ci sono tanti
problemi che si possono elencare, che devono essere risolti, ma che
– tutti – non vengono risolti se Dio non viene messo al
centro, se Dio non diventa nuovamente visibile nel mondo, se non
diventa determinante nella nostra vita e se non entra anche attraverso
di noi in modo determinante nel mondo. In questo, ritengo, si decide
oggi il destino del mondo in questa situazione drammatica: se Dio
– il Dio di Gesù Cristo – c’è e viene riconosciuto come
tale, o se scompare. Noi ci preoccupiamo che sia presente. Che cosa
dovremmo fare? In ultima istanza? Ci rivolgiamo a Lui! Noi celebriamo
questa Messa votiva dello Spirito Santo, invocandoLo: «Lava quod
est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium. Flecte
quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium».
Lo invochiamo affinché irrighi, scaldi, raddrizzi, affinché ci pervada
con la forza della sua sacra fiamma e rinnovi la terra. Per questo
lo preghiamo di tutto cuore in questo momento, in questi giorni.
Amen.
Il Discorso inaugurale
Eminenze, Eccellenze, cari Confratelli!
Vorrei innanzitutto salutarVi di cuore ed esprimere la mia gioia,
perché ci è dato di completare ora la visita pastorale, interrotta
nel 2005, avendo così la possibilità di lavorare ancora una volta
insieme su tutto il panorama di questioni che ci preoccupano. Ho
ancora un vivo ricordo della Visita ad limina del 2005,
quando nella Congregazione per la Dottrina della Fede abbiamo parlato
insieme di problemi che saranno nuovamente in discussione anche
in questi giorni. Mi è ancora ben presente l’atmosfera di impegno
interiore d’allora, per far sì che la Parola del Signore sia viva
e raggiunga i cuori degli uomini di questo tempo, perché la Chiesa
sia piena di vita. Nella nostra comune situazione difficile a causa
di una cultura secolarizzata, cerchiamo di comprendere la missione
affidataci dal Signore e di compierla il meglio possibile.
Non ho potuto preparare un vero discorso; vorrei ora, in vista
dei singoli grandi complessi di problemi che toccheremo, fare solo
qualche «primo tentativo», che non intende presentare delle affermazioni
definitive, ma vuole soltanto avviare il colloquio. È questo un incontro
tra i Vescovi svizzeri e i vari Dicasteri della Curia, nei quali
si rendono visibili e sono rappresentati i singoli settori del nostro
compito pastorale. Ad alcuni di essi vorrei cercare di offrire qualche
commento. In accordo col mio passato, comincio con la Congregazione
per la Dottrina della Fede, o meglio: col tema della fede. Già nell’omelia
ho cercato di dire che, in tutto il travaglio del nostro tempo, la
fede deve veramente avere la priorità. Due generazioni fa, essa poteva
forse essere ancora presupposta come una cosa naturale: si cresceva
nella fede; essa, in qualche modo, era semplicemente presente come
una parte della vita e non doveva essere cercata in modo particolare.
Aveva bisogno di essere plasmata ed approfondita, appariva però come
una cosa ovvia. Oggi appare naturale il contrario, che cioè in fondo
non è possibile credere, che di fatto Dio è assente. In ogni caso,
la fede della Chiesa sembra una cosa del lontano passato. Così anche
cristiani attivi hanno l’idea che convenga scegliere per sé, dall’insieme
della fede della Chiesa, le cose che si ritengono ancora sostenibili
oggi. E soprattutto ci si dà da fare per compiere mediante l’impegno
per gli uomini, per così dire, contemporaneamente anche il proprio
dovere verso Dio. Questo, però, è l’inizio di una specie di «giustificazione
mediante le opere»: l’uomo giustifica se stesso e il mondo in cui
svolge quello che sembra chiaramente necessario, ma manca la luce
interiore e l’anima di tutto. Perciò credo che sia importante prendere
nuovamente coscienza del fatto che la fede è il centro di tutto – «Fides
tua te salvum fecit» – dice il Signore ripetutamente a
coloro che ha guarito. Non è il tocco fisico, non è il gesto esteriore
che decide, ma il fatto che quei malati hanno creduto. E anche noi
possiamo servire il Signore in modo vivace soltanto se la fede diventa
forte e si rende presente nella sua abbondanza.
Vorrei sottolineare in questo contesto due punti cruciali. Primo:
la fede è soprattutto fede in Dio. Nel cristianesimo non si tratta
di un enorme fardello di cose diverse, ma tutto ciò che dice il Credo
e che lo sviluppo della fede ha svolto esiste solo per rendere più
chiaro alla nostra vista il volto di Dio. Egli esiste ed Egli vive;
in Lui crediamo; davanti a Lui, in vista di Lui, nell’essere-con
Lui e da Lui viviamo. Ed in Gesù Cristo, Egli è, per così dire, corporalmente
con noi. Questa centralità di Dio deve, secondo me, apparire in modo
completamente nuovo in tutto il nostro pensare ed operare. È ciò
che poi anima anche le attività che, in caso contrario, possono facilmente
decadere in attivismo e diventare vuote. Questa è la prima cosa che
vorrei sottolineare: che la fede in realtà guarda decisamente verso
Dio, e così spinge pure noi a guardare verso Dio e a metterci in
movimento verso di Lui.
L’altra cosa è che non possiamo inventare noi stessi la fede componendola
di pezzi «sostenibili», ma che crediamo insieme con la Chiesa. Non
tutto ciò che insegna la Chiesa possiamo comprendere, non tutto deve
essere presente in ogni vita. È però importante che siamo con-credenti
nel grande Io della Chiesa, nel suo Noi vivente, trovandoci così
nella grande comunità della fede, in quel grande soggetto, in cui
il Tu di Dio e l’Io dell’uomo veramente si toccano; in cui il passato
delle parole della Scrittura diventa presente, i tempi si compenetrano
a vicenda, il passato è presente e, aprendosi verso il futuro, lascia
entrare nel tempo il fulgore dell’eternità, dell’Eterno. Questa forma
completa della fede, espressa nel Credo, di una fede in e con la
Chiesa come soggetto vivente, nel quale opera il Signore – questa
forma di fede dovremmo cercare di mettere veramente al centro delle
nostre attività. Lo vediamo anche oggi in modo molto chiaro: lo sviluppo,
là dove è stato promosso in modo esclusivo senza nutrire l’anima,
reca danni. Allora le capacità tecniche crescono, sì, ma da esse
emergono soprattutto nuove possibilità di distruzione. Se insieme
con l’aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo, insieme con l’apprendimento
di tutto ciò che l’uomo è capace di fare, di tutto ciò che la sua
intelligenza ha inventato e che la sua volontà rende possibile, non
viene contemporaneamente anche illuminata la sua anima e non arriva
la forza di Dio, si impara soprattutto a distruggere. E per questo,
credo, deve nuovamente farsi forte in noi la responsabilità missionaria:
se siamo lieti della nostra fede, ci sentiamo obbligati a parlarne
agli altri. Sta poi nelle mani di Dio in che misura gli uomini potranno
accoglierla.
Da questo argomento vorrei ora passare all’«Educazione Cattolica»,
toccando due settori. Una cosa che, penso, causa a tutti noi una
«preoccupazione» nel senso positivo del termine, è il fatto che la
formazione teologica dei futuri sacerdoti e degli altri insegnanti
ed annunciatori della fede debba essere buona; abbiamo quindi bisogno
di buone Facoltà teologiche, di buoni seminari maggiori e di adeguati
professori di teologia che comunichino non soltanto conoscenze, ma
formino ad una fede intelligente, così che fede diventi intelligenza
ed intelligenza diventi fede. A questo riguardo ho un desiderio molto
specifico. La nostra esegesi ha fatto grandi progressi; sappiamo
davvero molto sullo sviluppo dei testi, sulla suddivisione delle
fonti ecc., sappiamo quale significato può aver avuto la parola in
quell’epoca… Ma vediamo anche sempre di più che l’esegesi storico-critica,
se rimane soltanto storico-critica, rimanda la parola nel passato,
la rende una parola dei tempi di allora, una parola che, in fondo,
non ci parla affatto; e vediamo che la parola si riduce in frammenti
perché, appunto, essa si scioglie in tante fonti diverse. Il Concilio,
la Dei Verbum, ci ha detto che il metodo storico-critico
è una dimensione essenziale dell’esegesi, perché fa parte della natura
della fede dal momento che essa è factum historicum. Non
crediamo semplicemente a un’idea; il cristianesimo non è una filosofia,
ma un avvenimento che Dio ha posto in questo mondo, è una storia
che Egli in modo reale ha formato e forma come storia insieme con
noi. Per questo, nella nostra lettura della Bibbia l’aspetto storico
deve veramente essere presente nella sua serietà ed esigenza: dobbiamo
effettivamente riconoscere l’evento e, appunto, questo «fare storia»
da parte di Dio nel suo operare. Ma la Dei Verbum aggiunge
che la Scrittura, che conseguentemente deve essere letta secondo
i metodi storici, va letta anche come unità e deve essere letta nella
comunità vivente della Chiesa. Queste due dimensioni mancano in grandi
settori dell’esegesi. L’unità della Scrittura non è un fatto puramente
storico-critico, benché l’insieme, anche dal punto di vista storico,
sia un processo interiore della Parola che, letta e compresa sempre
in modo nuovo nel corso di successive relectures, continua
a maturare. Ma questa unità è in definitiva, appunto, un fatto teologico:
questi scritti sono un’unica Scrittura, comprensibili fino in fondo
solo se letti nell’analogia fidei come unità in cui c’è
un progresso verso Cristo e, inversamente, Cristo attira a sé tutta
la storia; e se, d’altra parte, questo ha la sua vitalità nella fede
della Chiesa. Con altre parole, mi sta molto a cuore che i teologi
imparino a leggere e ad amare la Scrittura così come, secondo la Dei
Verbum, il Concilio lo ha voluto: che vedano l’unità interiore
della Scrittura – una cosa aiutata oggi dall’«esegesi canonica»
(che senz’altro si trova ancora in un timido stadio iniziale) –
e che poi di essa facciano una lettura spirituale, che non è una
cosa esterna di carattere edificante, ma invece un immergersi interiormente
nella presenza della Parola. Mi sembra un compito molto importante
fare qualcosa in questo senso, contribuire affinché accanto, con
e nell’esegesi storico-critica sia data veramente un’introduzione
alla Scrittura viva come attuale Parola di Dio. Non so come realizzarlo
concretamente, ma credo che, sia nell’ambito accademico, sia nel
seminario, sia in un corso d’introduzione, si possano trovare dei
professori adeguati, affinché avvenga questo incontro attuale con
la Scrittura nella fede della Chiesa – un incontro sulla base del
quale diventa poi possibile l’annuncio.
L’altra cosa è la catechesi che, appunto, negli ultimi cinquant’anni
circa, da un lato, ha fatto grandi progressi metodologici, dall’altro,
però, si è persa molto nell’antropologia e nella ricerca di punti
di riferimento, cosicché spesso non si raggiungono neanche più i
contenuti della fede. Posso capirlo: addirittura al tempo in cui
io ero viceparroco – quindi 56 anni fa – risultava già
molto difficile annunciare nella scuola pluralistica, con molti genitori
e bambini non credenti, la fede, perché essa appariva un mondo totalmente
estraneo ed irreale. Oggi, naturalmente, la situazione è ancora peggiorata.
Tuttavia è importante che nella catechesi, che comprende gli ambienti
della scuola, della parrocchia, della comunità ecc., la fede continui
ad essere pienamente valorizzata, che cioè i bambini imparino veramente
che cosa sia «creazione», che cosa sia «storia della salvezza» realizzata
da Dio, che cosa, chi sia Gesù Cristo, che cosa siano i Sacramenti,
quale sia l’oggetto della nostra speranza… Io penso che noi tutti
dobbiamo, come sempre, impegnarci molto per un rinnovamento della
catechesi, nella quale sia fondamentale il coraggio di testimoniare
la propria fede e di trovare i modi affinché essa sia compresa ed
accolta. Poiché l’ignoranza religiosa ha raggiunto oggi un livello
spaventoso. E tuttavia, in Germania i bambini hanno almeno dieci
anni di catechesi, dovrebbero quindi in fondo sapere molte cose.
Per questo dobbiamo certamente riflettere in modo serio sulle nostre
possibilità di trovare vie per comunicare, anche se in modo semplice,
le conoscenze, affinché la cultura della fede sia presente.
E ora qualche osservazione sul «Culto divino». L’Anno Eucaristico,
a questo riguardo, ci ha donato molto. Posso dire che l’Esortazione
postsinodale è a buon punto. Sarà sicuramente un grande arricchimento.
Inoltre abbiamo avuto il documento della Congregazione per il Culto
divino circa la giusta celebrazione dell’Eucaristia, cosa molto importante.
Io credo che a seguito di tutto ciò man mano diventi chiaro che la
Liturgia non è un’«auto-manifestazione» della comunità la quale,
come si dice, in essa entra in scena, ma è invece l’uscire della
comunità dal semplice «essere-se-stessi» e l’accedere al grande banchetto
dei poveri, l’entrare nella grande comunità vivente, nella quale
Dio stesso ci nutre. Questo carattere universale della Liturgia deve
entrare nuovamente nella consapevolezza di tutti. Nell’Eucaristia
riceviamo una cosa che noi non possiamo fare, ma entriamo invece
in qualcosa di più grande che diventa nostro, proprio quando ci consegniamo
a questa cosa più grande cercando di celebrare la Liturgia veramente
come Liturgia della Chiesa. È poi connesso con ciò anche il famoso
problema dell’omelia. Dal punto di vista puramente funzionale posso
capirlo molto bene: forse il parroco è stanco o ha predicato già
ripetutamente o è anziano e i suoi incarichi superano le sue forze.
Se allora c’è un assistente per la pastorale che è molto capace nell’interpretare
la Parola di Dio in modo convincente, vien spontaneo dire: perché
non dovrebbe parlare l’assistente per la pastorale; lui riesce meglio,
e così la gente ne trae maggior profitto. Ma questo, appunto, è la
visione puramente funzionale. Bisogna invece tener conto del fatto
che l’omelia non è un’interruzione della Liturgia per una parte discorsiva,
ma che essa appartiene all’evento sacramentale, portando la Parola
di Dio nel presente di questa comunità. È il momento, in cui veramente
questa comunità come soggetto vuole essere chiamata in causa per
essere portata all’ascolto e all’accoglimento della Parola. Ciò significa
che l’omelia stessa fa parte del mistero, della celebrazione del
mistero, e quindi non può semplicemente essere slegata da esso. Soprattutto,
però, ritengo anche importante che il sacerdote non sia ridotto al
Sacramento e alla giurisdizione – nella convinzione che tutti
gli altri compiti potrebbero essere assunti anche da altri –
ma che si conservi l’integrità del suo incarico. Il sacerdozio è
una cosa anche bella soltanto se c’è da compiere una missione che
è un tutt’uno, dal quale non si può tagliare qua e là qualcosa. E
a questa missione appartiene già da sempre – anche nel culto
antico-testamentario – il dovere del sacerdote di collegare
col sacrificio la Parola che è parte integrante dell’insieme. Dal
punto di vista puramente pratico dobbiamo poi certamente provvedere
a fornire i sacerdoti degli aiuti necessari perché possano svolgere
in modo giusto anche il ministero della Parola. In linea di massima,
questa unità interiore sia dell’essenza della Celebrazione eucaristica,
sia dell’essenza del ministero sacerdotale, è molto importante.
Il secondo tema, che vorrei toccare in questo contesto, riguarda
il sacramento della Penitenza la cui pratica in questi circa cinquanta
ultimi anni è progressivamente diminuita. Grazie a Dio esistono chiostri,
abbazie e santuari, verso i quali la gente va in pellegrinaggio e
dove il loro cuore si apre ed è anche pronto alla confessione. Questo
Sacramento lo dobbiamo veramente imparare di nuovo. Già da un punto
di vista puramente antropologico è importante, da una parte, riconoscere
la colpa e, dall’altra, esercitare il perdono. La diffusa mancanza
di una consapevolezza della colpa è un fenomeno preoccupante del
nostro tempo. Il dono del sacramento della Penitenza consiste quindi
non soltanto nel fatto che riceviamo il perdono, ma anche nel fatto
che ci rendiamo conto, innanzitutto, del nostro bisogno di perdono;
già con ciò veniamo purificati, ci trasformiamo interiormente e possiamo
poi comprendere anche meglio gli altri e perdonarli. Il riconoscimento
della colpa è una cosa elementare per l’uomo – è malato se non
l’avverte più – e altrettanto importante è per lui l’esperienza
liberatrice del ricevere il perdono. Per ambedue le cose il sacramento
della Riconciliazione è il luogo decisivo di esercizio. Inoltre lì
la fede diventa una cosa del tutto personale, non si nasconde più
nella collettività. Se l’uomo affronta la sfida e, nella sua situazione
di bisogno di perdono, si presenta, per così dire, indifeso davanti
a Dio, allora fa l’esperienza commovente di un incontro del tutto
personale con l’amore di Gesù Cristo.
Infine vorrei ancora occuparmi del ministero episcopale. Di questo,
in fondo, abbiamo implicitamente già parlato per tutto il tempo.
Mi sembra importante che i Vescovi, come successori degli Apostoli,
da una parte portino veramente la responsabilità delle Chiese locali
che il Signore ha loro affidate, facendo sì che lì la Chiesa come
Chiesa di Gesù Cristo cresca e viva. Dall’altra parte, essi devono
aprire le Chiese locali all’universale. Viste le difficoltà che gli
Ortodossi hanno con le Chiese autocefale, come anche i problemi dei
nostri amici protestanti di fronte alla disgregazione delle Chiese
regionali, ci rendiamo conto di quale grande significato abbia l’universalità,
quanto sia importante che la Chiesa si apra alla totalità, diventando
nell’universalità veramente un’unica Chiesa. Di questo, d’altra parte,
è capace soltanto se nel territorio suo proprio è viva. Questa comunione
deve essere alimentata dai Vescovi insieme con il Successore di Pietro
nello spirito di una consapevole successione al Collegio degli Apostoli.
Tutti noi dobbiamo sforzarci continuamente di trovare in questo rapporto
vicendevole il giusto equilibrio, cosicché la Chiesa locale viva
la sua autenticità e, contemporaneamente, la Chiesa universale da
ciò riceva un arricchimento, affinché ambedue donino e ricevano e
così cresca la Chiesa del Signore.
Il Vescovo Grab ha già parlato delle fatiche dell’ecumenismo; è un
campo che devo solo affidare al cuore di tutti Voi. Nella Svizzera
siete posti a confronto quotidianamente con questo compito che è
faticoso, ma crea anche gioia. Penso che importanti siano, da un
lato, i rapporti personali, nei quali ci riconosciamo e ci stimiamo
l’un l’altro in modo immediato come credenti e, come persone spirituali,
ci purifichiamo e ci aiutiamo anche a vicenda. Dall’altro lato, si
tratta – come ha già detto il Vescovo Grab – di farsi garanti
dei valori essenziali, portanti, provenienti da Dio della nostra
società. In questo campo, tutti insieme – protestanti, cattolici
ed ortodossi – abbiamo un grande compito. E sono lieto che stia
crescendo la consapevolezza di questo. Nell’occidente è la Chiesa
in Grecia che, pur avendo ogni tanto qualche problema con i Latini,
dice sempre più chiaramente: in Europa possiamo svolgere il nostro
compito soltanto se ci impegniamo insieme per la grande eredità cristiana.
Anche la Chiesa in Russia lo vede sempre di più ed altrettanto i
nostri amici protestanti sono consapevoli di questo fatto. Io penso
che, se impariamo ad agire in questo campo insieme, possiamo realizzare
una buona parte di unità anche là dove la piena unità teologica e
sacramentale non è ancora possibile.
Per concludere vorrei esprimerVi ancora una volta la mia gioia per
la Vostra visita, augurandoVi molti colloqui fruttuosi durante questi
giorni.
Il Discorso conlcusivo
Vorrei in primo
luogo ringraziare tutti per questo incontro, che mi sembra molto
importante come esercizio dell’affetto collegiale, come manifestazione
della nostra comune responsabilità per la Chiesa e per il Vangelo
in questo momento del mondo. Grazie per tutto! Mi dispiace che a
causa di altri impegni, soprattutto di Visite ad
limina (in questi giorni è il turno dei Vescovi tedeschi), non
potevo essere con Voi. Avrei realmente avuto il desiderio di sentire
la voce dei Vescovi svizzeri, ma si offriranno forse altre occasioni,
e, naturalmente, di sentire anche il dialogo tra la Curia Romana
e i Vescovi svizzeri: nella Curia Romana parla anche sempre il Santo
Padre nella sua responsabilità verso la Chiesa intera. Grazie, quindi,
per questo incontro che – mi sembra – ci aiuta tutti, perché
è per tutti un’esperienza dell’unità della Chiesa, ed è anche un’esperienza
della speranza che ci accompagna in tutte le difficoltà che ci circondano.
Vorrei chiedere scusa anche per il fatto che mi sono presentato già
nel primo giorno senza un testo scritto; naturalmente, un po’ avevo
già pensato, ma non avevo trovato il tempo di scrivere. E così anche
in questo momento mi presento con questa povertà; ma forse essere
povero in tutti i sensi conviene anche ad un Papa in questo momento
della storia della Chiesa. In ogni caso, non posso adesso offrire
un grande discorso, come sarebbe giusto dopo un incontro con questi
frutti. Devo dire infatti che avevo già letto la sintesi delle Vostre
discussioni ed ora l’ho ascoltata con grande attenzione: mi sembra
un testo molto ben ponderato e ricco; risponde realmente agli interrogativi
essenziali che ci occupano sia per l’unità della Chiesa nel suo insieme
sia per le questioni specifiche della Chiesa in Svizzera. Mi sembra
che realmente tracci la strada per i prossimi anni e dimostri la
nostra volontà comune di servire il Signore. Un testo molto ricco.
Leggendolo ho pensato: sarebbe un po’ assurdo se adesso cominciassi
a parlare di nuovo su questi temi sui quali si è discusso tre giorni
con profondità ed intensità. Vedo qui il risultato condensato e ricco
del lavoro fatto; aggiungere ancora qualcosa su singoli punti mi
sembra molto difficile, anche perché conosco il risultato del lavoro,
ma non la viva voce di quanti sono intervenuti nelle discussioni.
Perciò ho pensato che forse è giusto ritornare ancora una volta,
stasera nella conclusione, sui grandi temi che ci occupano e che
sono, in definitiva, il fondamento di tutti i dettagli – anche se
ogni dettaglio, ovviamente, è importante.
Nella Chiesa l’istituzione non è soltanto una struttura esteriore,
mentre il Vangelo sarebbe puramente spirituale. In realtà, Vangelo
e Istituzione sono inseparabili, perché il Vangelo ha un corpo, il
Signore ha un corpo in questo nostro tempo. Perciò le questioni che
a prima vista appaiono quasi soltanto istituzionali, sono in realtà
questioni teologiche e questioni centrali, perché vi si tratta della
realizzazione e concretizzazione del Vangelo nel nostro tempo. Pertanto,
la cosa giusta è ora ribadire ancora una volta le grandi prospettive
entro le quali si muove tutta la nostra riflessione. Mi permetto,
con l’indulgenza e la generosità dei membri della Curia Romana, di
ritornare alla lingua tedesca, perché abbiamo ottimi interpreti,
che altrimenti resterebbero disoccupati. Ho pensato a due temi specifici,
dei quali ho già parlato e che adesso vorrei ulteriormente approfondire.
Ancora, quindi, il tema «Dio». Mi è venuta in mente la parola di
sant’Ignazio: «Il cristianesimo non è opera di persuasione, ma di
grandezza» (Lettera ai Romani 3,3). Non dovremmo permettere che la
nostra fede sia resa vana dalle troppe discussioni su molteplici
particolari meno importanti, ma aver invece sempre sotto gli occhi
in primo luogo la sua grandezza. Mi ricordo, quando negli anni ottanta-novanta
andavo in Germania, mi si chiedevano delle interviste, e sempre sapevo
già in anticipo le domande. Si trattava dell’ordinazione delle donne,
della contraccezione, dell’aborto e di altri problemi come questi
che ritornano in continuazione. Se noi ci lasciamo tirare dentro
queste discussioni, allora si identifica la Chiesa con alcuni comandamenti
o divieti e noi facciamo la figura di moralisti con alcune convinzioni
un po’ fuori moda, e la vera grandezza della fede non appare minimamente.
Perciò ritengo cosa fondamentale mettere sempre di nuovo in rilievo
la grandezza della nostra fede – un impegno dal quale non dobbiamo
permettere che ci distolgano simili situazioni.
Sotto questo aspetto vorrei ora continuare completando le nostre
riflessioni di martedì scorso ed insistere ancora una volta: è importante
soprattutto curare il rapporto personale con Dio, con quel Dio che
si è mostrato a noi in Cristo. Agostino ha sottolineato ripetutamente
i due lati del concetto cristiano di Dio: Dio è Logos, e
Dio è Amor – fino al punto di farsi totalmente piccolo,
di assumere un corpo umano e alla fine di darsi come pane nelle nostre
mani. Questi due aspetti del concetto cristiano di Dio dovremmo sempre
tenere presenti e far presenti. Dio è Spiritus creator,
è Logos, è ragione. E per questo la nostra fede è una cosa
che ha da fare con la ragione, può essere trasmessa mediante la ragione
e non deve nascondersi davanti alla ragione, neanche a quella del
nostro tempo. Ma questa ragione eterna ed incommensurabile, appunto,
non è soltanto una matematica dell’universo e ancora meno qualche
prima causa che, dopo aver provocato il Big Bang, si è ritirata.
Questa ragione, invece, ha un cuore, tanto da poter rinunciare alla
propria immensità e farsi carne. E solo in ciò sta, secondo me, l’ultima
e vera grandezza della nostra concezione di Dio. Sappiamo: Dio non
è un’ipotesi filosofica, non è qualcosa che forse esiste, ma noi
Lo conosciamo ed Egli conosce noi. E possiamo conoscerLo sempre meglio,
se rimaniamo in colloquio con Lui.
Per questo è un compito fondamentale della pastorale, insegnare a
pregare ed impararlo personalmente sempre di più. Esistono oggi scuole
di preghiera, i gruppi di preghiera; si vede che la gente lo desidera.
Molti cercano la meditazione da qualche parte altrove, perché pensano
di non poter trovare nel cristianesimo la dimensione spirituale.
Noi dobbiamo mostrare loro di nuovo che questa dimensione spirituale
non solo esiste, ma che è la fonte di tutto. A questo scopo dobbiamo
moltiplicare tali scuole di preghiera, del pregare insieme, dove
si può imparare la preghiera personale in tutte le sue dimensioni:
come silenzioso ascolto di Dio, come ascolto che penetra nella sua
Parola, penetra nel Suo silenzio, sonda il Suo operare nella storia
e nella mia persona; comprendere anche il Suo linguaggio nella mia
vita e poi imparare a rispondere nel pregare con le grandi preghiere
dei Salmi dell’Antico e del Nuovo Testamento. Da noi stessi non abbiamo
le parole per Dio, ma ci sono state donate delle parole: lo Spirito
Santo stesso ha già formulato parole di preghiera per noi; possiamo
entrarci, pregare con esse e così imparare poi anche la preghiera
personale, sempre di più «imparare» Dio e così divenire certi di
Lui, anche se tace – diventare lieti in Dio. Questo intimo essere
con Dio e quindi l’esperienza della presenza di Dio è ciò che sempre
di nuovo ci fa, per così dire, sperimentare la grandezza del cristianesimo
e ci aiuta poi anche ad attraversare tutte le piccolezze, tra le
quali, certamente, esso deve poi essere vissuto e – giorno per
giorno, soffrendo ed amando, nella gioia e nella tristezza –
essere realizzato.
E da questa prospettiva si vede, secondo me, il significato della
Liturgia anche come scuola, appunto, di preghiera, nella quale il
Signore stesso ci insegna a pregare, nella quale preghiamo con la
Chiesa, sia nella celebrazione semplice ed umile con solo pochi fedeli,
sia anche nella festa della fede. L’ho percepito nuovamente proprio
ora nei vari colloqui, quanto importante sia per i fedeli, da una
parte, il silenzio nel contatto con Dio e, dall’altra, la festa della
fede, quanto importante poter vivere la festa. Anche il mondo ha
le sue feste. Nietzsche addirittura ha detto: Solo se Dio non esiste
possiamo far festa. Ma ciò è un’assurdità: solo se Dio c’è ed Egli
ci tocca, può esserci una vera festa. E sappiamo come queste feste
della fede spalancano i cuori della gente e producono impressioni
che aiutano per il futuro. Io l’ho visto nuovamente nelle mie visite
pastorali in Germania, in Polonia, in Spagna, che lì la fede è vissuta
come festa e che essa accompagna poi le persone e le guida.
Vorrei in questo contesto menzionare ancora un’altra cosa che mi
ha molto colpito ed impressionato durevolmente. Nell’ultima opera,
rimasta incompiuta, di san Tommaso d’Aquino, il Compendium Theologiae,
che egli intendeva strutturare semplicemente secondo le tre virtù
teologali fede, speranza, carità, il grande Dottore era giunto a
cominciare e parzialmente sviluppare il capitolo sulla speranza.
Lì egli identifica, per così dire, la speranza con la preghiera:
il capitolo sulla speranza è al contempo il capitolo sulla preghiera.
La preghiera è speranza in atto. E, di fatto, nella preghiera si
schiude la vera ragione, per cui ci è possibile sperare: Noi possiamo
entrare in contatto con il Signore del mondo, Egli ci ascolta e noi
possiamo ascoltare Lui. Questo è ciò a cui alludeva sant’Ignazio
e che io volevo ricordarVi oggi ancora una volta: «Ou peismones
to ergon, alla megethous estin ho Christianismos» (Rom 3,3)
– la cosa veramente grande nel Cristianesimo, che non dispensa dalle
cose piccole e quotidiane, ma che non deve neanche essere coperta
da esse, è questo poter entrare in contatto con Dio.
La seconda cosa, che proprio in questi giorni mi è tornata in mente,
riguarda la morale. Sento spesso dire che una nostalgia di Dio, di
spiritualità, di religione esiste oggi nelle persone e che si ricomincia
anche a vedere nella Chiesa una possibile interlocutrice, dalla quale,
a questo riguardo, è possibile ricevere qualcosa. (C’è stato un periodo
in cui questo lo si cercava in fondo solo nelle altre religioni).
Cresce nuovamente la consapevolezza: la Chiesa è una grande portatrice
di esperienza spirituale; è come un albero, nel quale possono porre
il loro nido gli uccelli, anche se poi vogliono di nuovo volar via
– ma è, appunto, il luogo dove ci si può posare per un certo tempo.
Quello che invece risulta molto difficile alla gente è la morale
che la Chiesa proclama. Su questo ho riflettuto – ci rifletto
già da molto tempo – e vedo sempre più chiaramente che, nella
nostra epoca, la morale si è come divisa in due parti. La società
moderna non è semplicemente senza morale, ma ha, per così dire, «scoperto»
e rivendica un’altra parte della morale che, nell’annuncio della
Chiesa negli ultimi decenni e anche di più, forse non è stata abbastanza
proposta. Sono i grandi temi della pace, della non violenza, della
giustizia per tutti, della sollecitudine per i poveri e del rispetto
della creazione. Questo è diventato un insieme etico che, proprio
come forza politica, ha un grande potere e costituisce per molti
la sostituzione o la successione della religione. In luogo della
religione, che è vista come metafisica e cosa dell’al di là – forse
anche come cosa individualistica – entrano i grandi temi morali
come l’essenziale che poi conferisce all’uomo dignità e lo impegna.
Questo è un aspetto, che cioè questa moralità esiste ed affascina
anche i giovani, che si impegnano per la pace, per la non violenza,
per la giustizia, per i poveri, per la creazione. E sono davvero
grandi temi morali, che appartengono del resto anche alla tradizione
della Chiesa. I mezzi che si offrono per la loro soluzione sono poi
spesso molto unilaterali e non sempre credibili, ma su questo non
dobbiamo soffermarci ora. I grandi temi sono presenti.
L’altra parte della morale, che non di rado viene colta in modo assai
controverso dalla politica, riguarda la vita. Fa parte di essa l’impegno
per la vita, dalla concezione fino alla morte, cioè la sua difesa
contro l’aborto, contro l’eutanasia, contro la manipolazione e contro
l’auto-legittimazione dell’uomo a disporre della vita. Spesso si
cerca di giustificare questi interventi con gli scopi apparentemente
grandi di poter con ciò essere utili alle generazioni future e così
appare addirittura come cosa morale anche il prendere nelle proprie
mani la vita stessa dell’uomo e manipolarla. Ma, dall’altra parte,
esiste anche la consapevolezza che la vita umana è un dono che richiede
il nostro rispetto e il nostro amore dal primo fino all’ultimo momento,
anche per i sofferenti, gli handicappati e i deboli. In questo contesto
si pone poi anche la morale del matrimonio e della famiglia. Il matrimonio
viene, per così dire, sempre di più emarginato. Conosciamo l’esempio
di alcuni Paesi, dove è stata fatta una modifica legislativa, secondo
la quale il matrimonio adesso non è più definito come legame tra
uomo e donna, ma come un legame tra persone; con ciò ovviamente è
distrutta l’idea di fondo e la società, a partire dalle sue radici,
diventa una cosa totalmente diversa. La consapevolezza che sessualità,
eros e matrimonio come unione tra uomo e donna vanno insieme – «I
due saranno una sola carne», dice la Genesi – questa consapevolezza
s’attenua sempre di più; ogni genere di legame sembra assolutamente
normale – il tutto presentato come una specie di moralità della non-discriminazione
e un modo di libertà dovuta all’uomo. Con ciò, naturalmente, l’indissolubilità
del matrimonio è diventata un’idea quasi utopica che, proprio anche
in molte persone della vita pubblica, appare smentita. Così anche
la famiglia si disfa progressivamente. Certo, per il problema della
diminuzione impressionante del tasso di natalità esistono molteplici
spiegazioni, ma sicuramente ha in ciò un ruolo decisivo anche il
fatto che si vuole avere la vita per se stessi, che ci si fida poco
del futuro e che, appunto, si ritiene quasi non più realizzabile
la famiglia come comunità durevole, nella quale può poi crescere
la generazione futura.
In questi ambiti, dunque, il nostro annuncio si scontra con una consapevolezza
contraria della società, per così dire, con una specie di antimoralità
che si appoggia su di una concezione della libertà vista come facoltà
di scegliere autonomamente senza orientamenti predefiniti, come non-discriminazione,
quindi come approvazione di ogni tipo di possibilità, ponendosi così
in modo autonomo come eticamente corretto. Ma l’altra consapevolezza
non è scomparsa. Essa esiste, e io penso che noi dobbiamo impegnarci
per ricollegare queste due parti della moralità e rendere evidente
che esse vanno inseparabilmente unite tra loro. Solo se si rispetta
la vita umana dalla concezione fino alla morte, è possibile e credibile
anche l’etica della pace; solo allora la non violenza può esprimersi
in ogni direzione, solo allora accogliamo veramente la creazione
e solo allora si può giungere alla vera giustizia. Penso che in ciò
abbiamo davanti un grande compito: da una parte, non far apparire
il cristianesimo come semplice moralismo, ma come dono nel quale
ci è dato l’amore che ci sostiene e ci fornisce poi la forza necessaria
per saper «perdere la propria vita»; dall’altra, in questo contesto
di amore donato, progredire anche verso le concretizzazioni, per
le quali il fondamento ci è sempre offerto dal Decalogo che, con
Cristo e con la Chiesa, dobbiamo leggere in questo tempo in modo
progressivo e nuovo.
Questi erano dunque i temi che credevo di dover e poter ancora aggiungere.
Vi ringrazio per la Vostra indulgenza e per la Vostra pazienza. Speriamo
che il Signore ci aiuti tutti nel nostro cammino. |