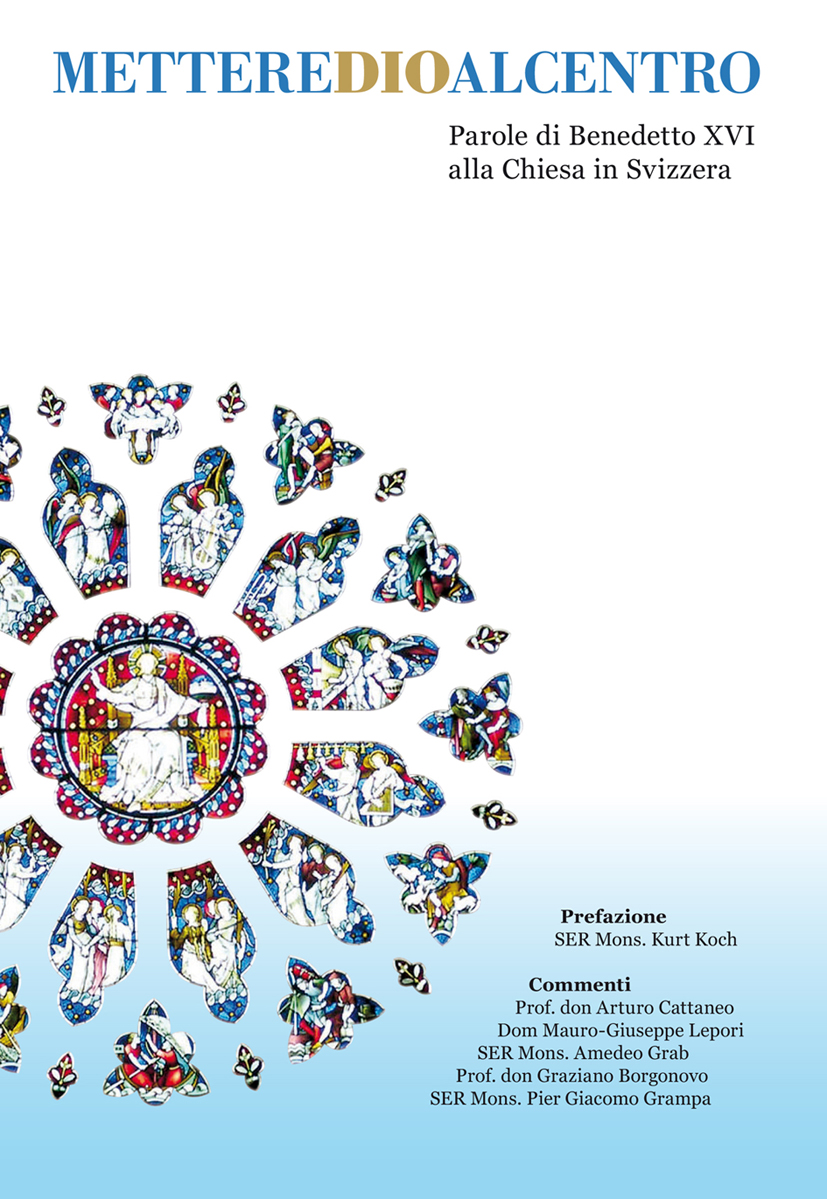|
All'origine: un invito totalmente gratuito
Un invito disprezzato
La via del rinnovamento:
ripartire dall'esperienza di Dio
Imparare e insegnare a pregare
Per un cristianesimo lieto: la speranza
L'importanza del rapporto personale con Dio - «Io
sono con te»
Leggendo l’omelia e i discorsi che il Santo Padre
ha tenuto ai Vescovi svizzeri in Visita ad limina nel novembre
2006, mi è venuta alla mente la scena della vocazione di Mosè (Es
3,7-12). Il Signore appare a Mosè nel roveto ardente e gli esprime
subito la ragione del suo manifestarsi: «Ho osservato la miseria
del mio popolo… Sono sceso per liberarlo…». Poi, di colpo, Dio lancia
a Mosè un ordine, che è la sua vocazione, come se scoccasse una freccia
che non ammette il minimo errore nel colpire il suo bersaglio: «Ora
va’! Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè
sente tutta la sua inadeguatezza, percepisce quanto è sproporzionata
una tale missione, e obietta a Dio il gemito della sua fragilità:
«Chi sono io per andare dal faraone e per far uscire dall’Egitto
gli Israeliti?» La vocazione alla quale Dio lo chiama, lo mette in
crisi fino alla radice della sua identità. Non obietta tanto quello
che gli manca in quanto a forze e capacità, ma il sentimento dell’inconsistenza
del suo «io», della piccolezza della sua persona, la miseria della
sua identità: «Chi sono io?». Per compiere la missione di liberare
il popolo che Dio gli vuole affidare, non gli mancano solo i mezzi:
è lui stesso che viene meno, è la sua stessa persona che è inadeguata,
che, in un certo senso, non c’è.
Dio allora non gli risponde: «Sta tranquillo, ce la farai, hai le
qualità necessarie, abbi fiducia in te stesso!». Gli dice soltanto:
«Io sarò con te!» (Es 3,12).
È come se Benedetto XVI avesse dato la stessa risposta ai Vescovi
svizzeri riuniti presso di lui per essere confortati nella loro vocazione
e missione di pastori del popolo, di un popolo del ventunesimo secolo
che sembra sempre più soggetto alla perdita della libertà, che rinuncia
alla libertà di pensare, agire, amare con verità. Gesù Cristo continua
a mandare i suoi apostoli e i suoi discepoli verso l’uomo d’oggi,
reso schiavo da poteri e ideologie ben più insidiosi del faraone
d’Egitto; e chi è mandato prova sempre più acutamente lo smarrimento
di Mosè, uno smarrimento che penetra la coscienza di se stessi: «Chi
sono io? Chi sono io per poter compiere questa missione?».
Ecco allora che Pietro, oggi ancora, ricorda ai suoi fratelli, confermandoli
nella fede, che l’unica risposta a questa domanda smarrita, l’unica
risposta che consola e dà forza, è quella di Dio stesso: «Io sono
con te!». Una risposta che nel Dio fatto uomo, morto per noi e risorto,
è diventata ancora più decisa e coinvolgente, così come è diventata
più universale la missione: «Mi è stato dato ogni potere in cielo
e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni […]. Ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo!» (Mt 28,18-20).
È questo: «Io sono con te!» di Dio, come risposta alla domanda sull’identità
che deve avere il cristiano, sia esso pastore o semplice fedele,
per adempiere la missione della Chiesa nella società di oggi, che
risuona in tutte le parole che il Santo Padre ha rivolto ai Vescovi
svizzeri.
È in questa luce che possiamo capire, e soprattutto accogliere, il
forte e insistente richiamo alla preghiera che il Papa fa in questi
discorsi. «È importante soprattutto curare il rapporto personale
con Dio, con quel Dio che si è mostrato a noi in Cristo» (Discorso
conclusivo).
Nelle situazioni e nei tempi in cui la missione della Chiesa si fa
più difficile, in cui essa è più osteggiata, e in cui affiorano più
evidenti i segni dell’umana fragilità e impotenza, la tentazione
che insidia immancabilmente il cristiano, e spesso soprattutto i
responsabili del gregge, è quella di dimenticare la presenza di Dio,
la presenza del Risorto, di cui la Chiesa è segno e strumento. Si
dimentica e si trascura il fatto che Dio rimane con noi. Si continua,
questo sì!, come Mosè, a chiedersi: «Chi sono io? Chi siamo noi?»,
ma è come se non si riuscisse più ad ascoltare la risposta consolante
di Dio: «Io sono con te!».
È ad ascoltare questa risposta di Dio, questa risposta essenziale,
l’unica necessaria, che il Papa ha voluto richiamare i nostri Vescovi
e noi tutti attraverso di loro. Perché questa risposta ci identifica,
ci dà un’identità, è la risposta che permette all’uomo di capire
chi è, quale è la sua natura, in che consiste il mistero del suo
cuore. Solo se accoglie da Dio questa risposta alla domanda «chi
sono io?» l’uomo diventa capace di dire «io», cioè di essere qualcuno,
dentro la sua vita e la missione che è chiamato a compiere nella
vocazione specifica che Dio gli dà.
Vale la pena allora di evidenziare i punti salienti nel richiamo
del Santo Padre alla preghiera e la loro concatenazione.
All'origine: un invito totalmente gratuito
È utile rileggere un passo del Vangelo sul quale il Papa ha pronunciato
la sua omelia in apertura della Visita ad limina.
«Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della
cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: ‘Venite, è pronto’.
Ma tutti, all’unanimità, cominciarono a scusarsi. Il primo disse:
‘Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego, considerami
giustificato’. Un altro disse: ‘Ho comprato cinque paia di buoi e
vado a provarli; ti prego, considerami giustificato’. Un altro disse:
‘Ho preso moglie e perciò non posso venire’. Al suo ritorno il servo
riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato,
disse al servo: ‘Esci subito per le piazze e per le vie della città
e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi’» (Lc 14,16-21).
Il primo aspetto che va sottolineato è che la preghiera come rapporto
personale con Dio è sempre una risposta ad un’iniziativa gratuita
del Signore. Tutto parte dall’iniziativa di Dio; è Lui che offre
all’uomo il Suo desiderio di comunione, di amicizia. È in una totale
gratuità che il padrone fa invitare i ricchi e i poveri. Nessuno
degli invitati ha meritato questo invito. Stavano lavorando nel loro
campo, facendo del commercio, arando con i loro buoi, stavano intrattenendosi
con la loro sposa, oppure stavano mendicando sul ciglio della strada
un pezzo di pane, mostrando le loro membra storpie, stavano avanzando
a tentoni sulla strada perché erano ciechi, stavano magari maledicendo
la vita perché erano malati e poveri, ed ecco che piomba su di loro
un invito inatteso: il Signore, mediante il suo servo, dice loro:
«Venite a cenare con me! Venite a vivere con me un tempo gratuito
di amicizia, di comunione!».
Di fronte a questo invito inatteso e sorprendente, il vantaggio dei
poveri e dei disgraziati, rispetto ai ricchi e ai potenti, è che
non hanno niente da difendere di fronte alla gratuità dell’invito,
e, nella condizione in cui si trovano, possono meglio di tutti misurare
la sproporzione fra la loro condizione e il valore di ciò a cui sono
invitati dal Signore.
È questa gratuità di Dio nell’offrire all’uomo lo spazio infinito
della sua amicizia che non fallisce mai. Anche quando la sala che
Dio vuole riempire di invitati rimane vuota, «Dio non fallisce»,
dice il Papa, perché «la sala vuota diventa un’opportunità per chiamare
un maggior numero di persone. L’amore di Dio, l’invito di Dio, si
allarga» (Omelia).
Lo spazio gratuito della comunione con Lui, Dio non lo chiude. Per
questo la preghiera come rapporto personale col Signore è sempre
possibile, può sempre essere ripresa e rinnovata.
Un invito disprezzato
Ma questa gratuità evidenzia la vera natura del rifiuto dell’uomo:
il disprezzo di questa offerta. Nella parabola che il Papa ha commentato,
tutti quelli che rifiutano l’invito alla cena, avanzano delle giustificazioni
legate alla vita quotidiana di ogni essere umano: un campo, cinque
paia di buoi, un matrimonio; dunque i beni che si hanno, il lavoro
che si fa, le relazioni che definiscono un’esistenza.
Ora, bisogna notare che in questa parabola non si tratta della chiamata
a seguire il Signore lasciando il proprio campo, il proprio lavoro,
la propria famiglia per ricevere il centuplo e la vita eterna. Queste
persone sono chiamate soltanto ad andare da quel signore per una
cena festosa. Ma allora, il campo acquistato non può aspettare alcune
ore prima di essere visto? I buoi non possono attendere un po’ prima
di essere provati? La giovane donna che si è appena sposata non può
restare sola per poche ore, quando si ha tutta la vita coniugale
davanti a sé? Perché queste persone rifiutano l’invito? Le loro scuse
non tengono; nessuna è urgente, nessuna è veramente un’alternativa
al pasto offerto da questo signore.
La vera ragione del rifiuto è la poca importanza che questi invitati
attribuiscono all’invito, e dunque all’uomo che li invita. Se non
hanno paura di rifiutare, vuol dire che questo signore non ha nemmeno
potere, non è un re o un padrone potente. Capiamo allora che la sola
ragione per accettare il suo invito sarebbe stata la sua amicizia.
Egli invita al banchetto solo per amicizia e per far crescere l’amicizia.
È la sua amicizia che questi invitati rifiutano, è la sua amicizia
che disprezzano.
Il Papa, nella sua omelia, fa notare che questo disprezzo dell’amicizia
gratuita di Dio è in fondo la natura del peccato originale, e quindi
il punto attraverso il quale Adamo ha lasciato entrare il male nella
sua esistenza e in tutta la storia dell’umanità: «Adamo […] non era
soddisfatto dell’amicizia con Dio; era troppo poco per lui, volendo
essere lui stesso Dio. Considerò l’amicizia una dipendenza e si ritenne
un dio, come se egli potesse esistere da sé soltanto».
Coloro che rifiutano l’invito al banchetto del Signore continuano
a sprofondare in questa logica assurda, con la pretesa di «poter
esistere da sé soltanto», di non aver bisogno di Dio e della sua
amicizia per rendere più umana, più bella, più vera e lieta la loro
vita di tutti i giorni.
Gli invitati che rifiutano l’amicizia di Dio per ragioni futili,
descrivono allora perfettamente l’uomo d’oggi, l’uomo della società
occidentale scristianizzata. Non si tratta forse più tanto di un
rifiuto ragionato, motivato da altre convinzioni religiose o filosofiche.
Si tratta piuttosto della perdita della consapevolezza del significato
positivo che il rapporto con Dio può dare all’esistenza umana.
«Com’è possibile, si chiede Benedetto XVI ispirandosi a san Gregorio
Magno, che un uomo dica ‘no’ a ciò che vi è di più grande; che non
abbia tempo per ciò che è più importante; che chiuda in se stesso
la propria esistenza?».
La risposta del Papa in un certo senso scagiona l’uomo d’oggi e ne
descrive la povertà interiore: «In realtà, non hanno mai fatto l’esperienza
di Dio; non hanno mai preso ‘gusto’ di Dio; non hanno mai sperimentato
quanto sia delizioso essere ‘toccati’ da Dio! Manca loro questo ‘contatto’
– e con ciò il ‘gusto di Dio’».
La miseria dell’uomo d’oggi consiste nel rifiutare Dio senza conoscerlo.
Gli invitati al banchetto che rifiutano l’invito per fare e vivere
altro, sono così una parabola della nostra società in cui l’amicizia
offerta dal Signore non riguarda più la realtà della vita quotidiana,
non riguarda ciò che l’uomo possiede, il suo lavoro e la sua vita
affettiva e familiare. Non lo riguarda nel senso che l’uomo non vede
e non crede che l’amicizia col Signore possa avere un’influenza positiva
sulla vita reale, possa essere una pienezza da gustare dentro la
realtà quotidiana per renderla più umana e lieta.
Questa parabola descrive allora anche la natura della grande crisi
della «cristianità occidentale», della Chiesa nei paesi europei e
nordamericani, la grande crisi che ha svuotato le chiese, che ha
reso formale e sterile la vita di tante parrocchie, che ha laicizzato
tante istituzioni educative, assistenziali e culturali che la Chiesa
in passato aveva creato e animato con grande generosità. La crisi
non consiste anzitutto nel fatto che si pratica statisticamente di
meno e «si fa» meno per la Chiesa. Ciò è una conseguenza. La crisi
sta nel fatto che Gesù Cristo non è più percepito come qualcuno che
salva la nostra vita reale, quotidiana. E se le chiese si svuotano,
ciò dimostra forse che quando erano ancora piene, la crisi era già
presente, perché già non si vedeva più come il fatto di partecipare
alla Messa, di santificare la domenica, di partecipare a certi gesti
della Chiesa, di appartenere alle associazioni cattoliche, potesse
essere conveniente e vantaggioso per la vita reale dei fedeli, cioè
potesse rendere la vita migliore, più intensa, più umana, più felice.
Queste pratiche forse non erano già più vissute come esperienza e
rinnovo dell’avvenimento di Cristo che salva la vita dell’uomo qui
e ora.
Il Papa analizza questa situazione, ci aiuta a guardarla con verità.
Ce la mostra così com’è dalle sue radici, come crisi non di strutture,
ma di fede e di esperienza interiore, come fragilità del nostro cuore;
una crisi che, poco o tanto, ci tocca tutti. Un passo dell’omelia
descrive l’essenza di questa crisi come, potremmo dire, un’atrofia
del cuore. Il cuore della crisi dell’uomo contemporaneo è la crisi
del suo cuore, del cuore umano come capacità di amicizia con Dio:
«Quando l’uomo è occupato interamente col suo mondo, con le cose
materiali, con ciò che può fare, con tutto ciò che è fattibile e
che gli porta successo, con tutto ciò che può produrre o comprendere
da se stesso, allora la sua capacità di percezione nei confronti
di Dio s’indebolisce, l’organo volto a Dio deperisce, diventa incapace
di percepire ed insensibile. Egli non percepisce più il Divino, perché
il corrispondente organo in lui si è inaridito, non si è più sviluppato.
Quando utilizza troppo tutti gli altri organi, quelli empirici, allora
può accadere che proprio il senso di Dio si appiattisca; che questo
organo muoia; e che l’uomo, come dice san Gregorio, non percepisca
più lo sguardo di Dio, l’essere guardato da Lui – questa cosa preziosa
che è il fatto che il suo sguardo mi tocchi!» (Omelia).
L’uomo contemporaneo ha come perso il gusto di Dio, e perdendo questo
gusto, perde la dimensione più profonda di se stesso, perde il cuore,
il cuore assetato di vedere il Volto di Dio, di fissare il Suo sguardo.
La via del rinnovamento: ripartire dall'esperienta
di Dio
Come uscire da questa crisi in cui l’uomo sembra auto-immunizzarsi
dall’esperienza di Dio che sola può rinnovare il cuore e l’umanità?
Benedetto XVI propone una via in fondo molto semplice, fondandosi
su un giudizio che non censura la fragilità e il peccato dell’uomo:
non possiamo ripartire da noi stessi, da quello che siamo o facciamo
noi, da quello che pensiamo noi, dalle nostre buone intenzioni e
dai nostri sentimenti. Dobbiamo ripartire da Dio, e ripartire da
Dio come Lui riparte sempre dopo ogni fallimento della sua opera
di salvezza gratuita.
«Dio non fallisce», ci annuncia Benedetto XVI. Non fallisce perché
ricomincia sempre ad amare l’uomo. È necessario ripartire da Lui
e ripartire come riparte Lui, ripartire da Lui che rinnova, approfondisce
e dilata sempre di nuovo l’offerta del suo amore, della sua amicizia.
E più la gratuità divina si esprime e si manifesta di fronte al rifiuto
e al disprezzo dell’uomo, e più l’uomo è chiamato a diventare gratuito
nell’accogliere questa gratuità. La gratuità dell’uomo di fronte
alla gratuità di Dio consiste nel non volerla meritare, nell’accoglierla
con povertà, nell’accoglierla con la consapevolezza della propria
miseria.
Per questo è coi cuori poveri che Dio può ricominciare, che può recuperare
il fallimento dei suoi inviti alla comunione con Lui. Dio ricomincia
dai più miseri, perché Dio ricomincia sempre dalla sua misericordia
ed è con la sua misericordia che recupera tutto. È infatti la misericordia
di Dio che non fallisce mai, la misericordia che si è manifestata
totalmente in Cristo crocefisso. In Lui, veramente il Dio che fallisce
per il rifiuto degli uomini, vince nell’amore che redime. «Per mezzo
della croce di Cristo, Dio si è avvicinato alle genti, è uscito da
Israele ed è diventato il Dio del mondo. […] Il Dio che aveva ‘fallito’,
ora, attraverso il suo amore, porta davvero l’uomo a piegare le ginocchia,
e così vince il mondo con il suo amore» (Omelia).
La misericordia di Dio trasforma così il significato del vuoto creato
dal rifiuto dell’uomo. «La sala vuota diventa un’opportunità per
chiamare un maggior numero di persone. L’amore di Dio, l’invito di
Dio si allarga. […] Egli invita coloro che non possiedono nulla;
che hanno davvero fame, che non possono invitarlo, che non possono
dargli nulla» (Omelia).
Sì, ribadisce il Papa, «Dio non fallisce. ‘Fallisce’ continuamente,
ma proprio per questo non fallisce, perché ne trae nuove opportunità
di misericordia più grande, e la sua fantasia è inesauribile. Non
fallisce perché trova sempre nuovi modi per raggiungere gli uomini
e per aprire di più la sua grande casa, affinché si riempia del tutto.
Non fallisce perché non si sottrae alla prospettiva di sollecitare
gli uomini perché vengano a sedersi alla sua mensa, a prendere il
cibo dei poveri, nel quale viene offerto il dono prezioso, Dio stesso.
Dio non fallisce, nemmeno oggi. Anche se sperimentiamo tanti ‘no’,
possiamo esserne certi. Da tutta questa storia di Dio, a partire
da Adamo, possiamo concludere: Egli non fallisce. Anche oggi troverà
nuove vie per chiamare gli uomini e vuole avere con sé noi come suoi
messaggeri e suoi servitori».
Ci si lamenta molto della situazione delle nostre Chiese. Il vuoto
che si crea rattrista e deprime. Il Papa ci invita ad alzare lo sguardo,
ad avere uno sguardo di fede, memore del Signore e di come Lui sempre
ha agito. Siamo come il popolo d’Israele nel deserto: dimentichiamo
le meraviglie del Signore, e per questo non ripartiamo dalla fiducia
in Lui, impantanandoci nella fiducia in noi stessi e quindi nella
delusione. Benedetto XVI invece ci invita a guardare proprio il vuoto
che ci deprime come spazio della speranza, e a viverlo come tale.
Come? Con la preghiera, riempiendolo di rapporto con Dio, di esperienza
di Dio. Non è forse questo che ha sempre fatto e vissuto Gesù, costantemente
confrontato al rifiuto e alla chiusura degli uomini, quando pregava
nel deserto e nella notte, fino al deserto interiore del Getsemani
e la notte della Croce?
Allora, tutta la responsabilità e l’impegno della nostra libertà,
ecco che il Papa li concentra nella nostra scelta di starci al rapporto
personale col Signore. È questo che riempie le nostre sale vuote,
come per dirci che non è anzitutto il numero di persone che determina
la vitalità della Chiesa, ma l’accoglienza della presenza del Signore.
Sembra di risentire Gesù quando dice ai discepoli: «In verità vi
dico: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché
dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro»
(Mt 18,19-20).
Sì, possiamo rimanere in pochi, pochissimi; il problema non è il
numero, ma che quei pochi rimangano uniti nella preghiera, nel nome
di Gesù; che il rapporto personale con Dio in Cristo colmi il vuoto,
la pochezza e la fragilità delle nostre comunità e delle nostre persone.
L’insistenza di Benedetto XVI sulla preghiera è essenzialmente un’insistenza
sulla centralità di Dio come «soluzione» sempre possibile del male
dell’uomo e del mondo. Il Papa non insiste su una pratica, ma sul
rapporto con una Persona. Infatti, quando il mondo va male, quando
l’uomo va male, quando anche la Chiesa sembra in crisi, ciò che ci
manca non è anzitutto qualcosa, non è neanche un miglior programma,
ma Dio stesso. Ci manca il Signore. Ci manca Cristo.
L’attivismo, anche e soprattutto quello ecclesiastico, è la dimenticanza
di questo. «Anche noi corriamo un pericolo, avverte il Papa: Si può
fare molto, tanto nel campo ecclesiastico, tutto per Dio…, e in ciò
rimanere totalmente presso se stessi, senza incontrare Dio» (Omelia).
Mettere Dio al centro vuol dire anzitutto coltivare ed esprimere
la coscienza che Lui ci è indispensabile, che senza di Lui non possiamo
far nulla (cfr. Gv 15,5). Allora la preghiera è come il respiro di
quest’aria, l’espressione più adeguata alla sola risposta che può
soddisfare il nostro bisogno: la presenza del Dio vivo che ci salva.
«Si tratta della centralità di Dio – conclude il Santo Padre
nella sua omelia – e precisamente non di un dio qualunque, bensì
del Dio che ha il volto di Gesù Cristo. Questo, oggi, è importante.
Ci sono tanti problemi che si possono elencare, che devono essere
risolti, ma che – tutti – non vengono risolti se Dio non
viene messo al centro, se Dio non diventa nuovamente visibile nel
mondo, se non diventa determinante nella nostra vita e se non entra
anche attraverso di noi in modo determinante nel mondo. In questo,
ritengo, si decide oggi il destino del mondo in questa situazione
drammatica: se Dio – il Dio di Gesù Cristo – c’è e viene
riconosciuto come tale, o se scompare. Noi ci preoccupiamo che sia
presente. Che cosa dovremmo fare? In ultima istanza? Ci rivolgiamo
a Lui!».
Imparare e insegnare a pregare
Il Papa sembra allora non lasciare ai Vescovi e a tutti i fedeli
che una consegna prioritaria: quella di imparare a pregare. Imparare
a pregare per poter insegnare a pregare, per trasmettere, non certo
lezioni di preghiera, ma l’esperienza del rapporto vivo col Signore
come sostanza e pienezza del cristianesimo. È la grande insistenza
del Discorso conclusivo della Visita ad limina. Il Papa
richiama a non più disperdere energie nelle discussioni «su molteplici
particolari meno importanti», perché così si entra nel gioco di chi
vuole ridurre la Chiesa ad un’istituzione tesa soltanto ad affermare
«alcuni comandamenti e divieti». La Chiesa non è nel mondo per propugnare
una morale, o una filosofia, ma per incarnare e annunciare l’avvenimento
di un Dio fattosi uomo, morto e risorto per salvarci, e che rimane
con noi vivo fino alla fine del mondo. È questa «la grandezza della
nostra fede». La grandezza della fede cristiana è l’esperienza possibile
a tutti dell’avvenimento di Cristo.
È su questa convinzione che Benedetto XVI fonda l’importanza pastorale
e missionaria dell’esperienza della preghiera. Non si tratta anzitutto
di pregare affinché l’avvenimento cristiano si affermi e si diffonda,
ma per farne l’esperienza personale, perché esso sia un avvenimento
nella nostra vita. La missione della Chiesa non consiste principalmente
in qualcosa da fare, ma nell’essere un soggetto nuovo, un soggetto
coinvolto nell’avvenimento di Gesù Cristo.
Come si impara allora a pregare?
Si impara a pregare come si approfondisce un rapporto di amicizia.
E questo avviene intensificando sempre più il legame di parola e
di amore fra le persone. Il rapporto si approfondisce dialogando,
dove il dialogo è sempre un alternarsi e uno scambio di ascolto e
parola, di silenzio che ascolta e di parola che confida. Ma perché
il colloquio non rimanga un superficiale confronto di idee e pensieri,
il dialogo deve approfondire lo scambio di amore, cioè l’attenzione
del cuore e il dono di sé all’altro. È così che la preghiera si impara
sempre di più, come lo chiede il Papa: approfondendo il colloquio
e lo scambio di amore con Dio.
Questo metodo non è un’invenzione dell’uomo, ma è dettato dalla natura
stessa di Dio. Il Papa ci ricorda infatti che, come lo sottolinea
sant’Agostino, Dio è Logos e Amor. Dio è Parola
e Amore, e per questo il rapporto con Lui non può essere che colloquio
d’amore. La preghiera è dialogo d’amore con Dio. Dentro questo dialogo
c’è allora spazio per tutte le forme di preghiera: il silenzio, l’ascolto,
l’adorazione, la supplica, la lode, la festa…
La natura di Dio detta la natura del nostro rapporto con Lui. In
Cristo, Dio si è fatto conoscere dall’uomo come Logos e Amor totalmente
rivelati e donati. Per questo la preghiera cristiana ha un’originalità
insuperabile. Non ci può essere rapporto più stretto con Dio che
la preghiera cristiana, perché Dio – in Gesù Cristo – si
è reso totalmente accessibile alla capacità di relazione che Egli
stesso ha messo nel cuore di ogni essere umano. «L’ultima e vera
grandezza della nostra concezione di Dio» scrive il Papa, è Cristo,
il Logos divino che «ha un cuore, tanto da poter rinunciare
alla propria immensità e farsi carne». Per questo la preghiera come
rapporto d’amore con Lui coincide con la grandezza del cristianesimo.
Questo, il Santo Padre lo richiama evidentemente a noi cristiani,
e lo fa anche per scuoterci dalla distrazione e dalla negligenza
con cui spesso viviamo la nostra fede. La superficialità nel vivere
il cristianesimo sta soprattutto nel trascurare il tesoro della preghiera,
del rapporto personale con Dio così come ci è offerto gratuitamente
nel Verbo incarnato. La preghiera non è soltanto una pratica funzionale
ad altro, non è soltanto una soluzione di ripiego, di emergenza,
per far intervenire Dio là dove l’uomo si sente impotente. La preghiera
è il cuore e il centro dell’esperienza cristiana. Senza questo cuore,
tutta l’esperienza cristiana diventa futile, vuota di senso e di
sostanza, e tutti i problemi che sorgono nella comunità cristiana,
anche se reali, anche se gravi, sono affrontati con superficialità.
«Questo intimo essere con Dio – richiama ancora il Papa –
e quindi l’esperienza della presenza di Dio è ciò che sempre di nuovo
ci fa, per così dire, sperimentare la grandezza del cristianesimo
e ci aiuta poi anche ad attraversare tutte le piccolezze, tra le
quali, certamente, esso deve poi essere vissuto e – giorno per
giorno, soffrendo ed amando, nella gioia e nella tristezza –
essere realizzato» (Discorso conclusivo).
La vita delle comunità, la liturgia, l’educazione cristiana, tutto
ci è dato affinché l’incontro con Cristo diventi esperienza e vita.
Il Concilio infatti ci ha ricordato che la natura stessa della Chiesa
è di essere «il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima
unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Lumen
gentium, 1). Così, se l’esperienza dell’«intima unione con Dio»
non diventa personale, esperienza del cuore, è come se tutta la vita
ecclesiale di una persona, o di un’intera comunità, si svuotasse
del suo significato e diventasse sterile.
Contro questa superficialità il Papa domanda allora un lavoro. Lo
domanda anzitutto ai pastori, affinché i fedeli possano seguirli
e diventare a loro volta testimoni di un’esperienza di Dio sempre
possibile: «È un compito fondamentale della pastorale, insegnare
a pregare ed impararlo personalmente sempre di più. Esistono oggi
scuole di preghiera, i gruppi di preghiera; si vede che la gente
lo desidera. Molti cercano la meditazione da qualche parte altrove,
perché pensano di non poter trovare nel cristianesimo la dimensione
spirituale. Noi dobbiamo mostrare loro di nuovo che questa dimensione
spirituale non solo esiste, ma che è la fonte di tutto» (Discorso
conclusivo).
Il Papa parla di imparare e insegnare, di curare e mostrare l’esperienza
del rapporto personale con Dio. E questo lo porta a parlare di «scuole
di preghiera». Se la preghiera è una dimensione dimenticata e trascurata,
abbiamo bisogno di essere educati, rieducati, ad essa. È un bisogno
che la gente sente ed esprime, così come può, ma che spesso non trova
nella Chiesa un aiuto, una risposta. È necessario allora che il rapporto
vivo con Dio possa di nuovo essere «incontrato» in persone e comunità,
in luoghi e tempi, perché l’esperienza si comunica se in un modo
o nell’altro si è toccati da essa, si può entrare in essa. «A questo
scopo – propone Benedetto XVI – dobbiamo moltiplicare tali
scuole di preghiera, del pregare insieme, dove si può imparare la
preghiera personale in tutte le sue dimensioni: come silenzioso ascolto
di Dio, come ascolto che penetra nella sua Parola, penetra nel Suo
silenzio, sonda il Suo operare nella storia e nella mia persona;
comprendere anche il Suo linguaggio nella mia vita e poi imparare
a rispondere nel pregare con le grandi preghiere dei Salmi dell’Antico
e del Nuovo Testamento. Da noi stessi non abbiamo le parole per Dio,
ma ci sono state donate delle parole: lo Spirito Santo stesso ha
già formulato parole di preghiera per noi; possiamo entrarci, pregare
con esse e così imparare poi anche la preghiera personale, sempre
di più ‘imparare’ Dio e così divenire certi di Lui, anche se tace
– diventare lieti in Dio» (Discorso conclusivo).
Una scuola d’altronde è già in funzione, da sempre: la scuola della
Liturgia. Se si vivesse la Liturgia per imparare a pregare, quanti
abusi liturgici svanirebbero in un istante! Essa infatti sarebbe
vissuta con l’umile attenzione del desiderio di imparare, di ascoltare,
di domandare, di seguire la Chiesa che da due millenni prende i suoi
figli per mano, e se necessario in braccio, per insegnare loro il
colloquio col Dio che è Parola e Amore. Si scoprirebbe allora che
si impara solo dalla bellezza e dalla verità. Sì, la Liturgia è «scuola,
appunto, di preghiera, nella quale il Signore stesso ci insegna a
pregare, nella quale preghiamo con la Chiesa, sia nella celebrazione
semplice ed umile con solo pochi fedeli, sia anche nella festa della
fede» (Discorso conclusivo).
Per un cristianesimo lieto: la speranza
Certo, una tale «rete scolastica» adeguata e sufficiente
non si improvvisa. Ma il Santo Padre ci aiuta almeno a capire che
essa è una priorità, che tutti gli altri interventi per rinnovare
un tessuto cristiano, cioè pienamente umano, nella società attuale
non possono essere che conseguenza di questo lavoro di «irrigazione»
spirituale. Perché è da lì che rinasce un cristianesimo lieto, di
uomini e donne «lieti in Dio», e non scontenti di tutto e di tutti,
rivendicativi senza essere veramente propositivi, e quindi sterili
nel trasmettere al mondo la grandezza e bellezza dell’incontro con
Cristo.
In questi discorsi si percepisce con nettezza che quello che Benedetto
XVI ha offerto ai Vescovi svizzeri non è altro che una testimonianza
personale, frutto dell’esperienza di tutta una vita consacrata ad
amare Cristo e la sua Chiesa. Si capisce così, leggendo questi discorsi,
qual è il segreto della letizia e della pace con cui il Santo Padre
guida la barca della Chiesa oggi, in mezzo a flutti e scogli che
dovrebbero spaventarlo, tentarlo a fuggire. Invece, Pietro oggi,
come duemila anni fa, si lascia raggiungere dalla calda voce del
Signore: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» (Mt 14,27). Ed è
come se ci testimoniasse che è appunto nella preghiera che questa
voce lo raggiunge, per la pace e la letizia del suo cuore e il conforto
dei suoi fratelli Vescovi e di tutto il popolo.
Ma il vero nome di questa letizia è la speranza. Ce lo ricorda ancora
il Papa rifacendosi a san Tommaso d’Aquino che «identifica, per così
dire, la speranza con la preghiera. […] La preghiera è speranza in
atto. E, di fatto, nella preghiera si schiude la vera ragione, per
cui ci è possibile sperare: Noi possiamo entrare in contatto con
il Signore del mondo, Egli ci ascolta e noi possiamo ascoltare Lui.
[…] La cosa veramente grande nel Cristianesimo, che non dispensa
dalle cose piccole e quotidiane, ma che non deve neanche essere coperta
da esse, è questo poter entrare in contatto con Dio» (Discorso conclusivo).
Il frutto della preghiera che veramente incontra il Signore del mondo
è l’uomo che vive sperando. La speranza è la virtù che cambia tutto,
perché cambia la posizione del cuore di fronte a tutto. Il frutto
della preghiera è l’uomo che vive confidando in Dio, perché è certo
dell’amicizia di Dio. È questa conversione del cuore alla speranza
che cambia tutto, perché la speranza affida ogni cosa all’Onnipotente.
Pensiamo ancora una volta alla parabola del banchetto commentata
dal Papa nell’omelia ai Vescovi svizzeri. Cosa è cambiato nella vita
dei poveri, degli storpi, dei ciechi e degli zoppi che hanno accettato
l’invito al banchetto? Apparentemente, nulla. Alla fine del pasto,
a parte il fatto che hanno per una volta mangiato a sazietà, sono
ritornati alla loro vita, poveri, storpi, ciechi e zoppi come erano
prima di andarci. Ma hanno accolto l’amicizia del Signore, ed è in
quanto amici suoi che hanno potuto continuare la loro vita ordinaria,
pur miserabile. Ciò non ha cambiato niente; eppure ciò ha cambiato
tutto. Hanno potuto vivere con una coscienza nuova di loro stessi
e delle loro miserie. Hanno potuto vivere con la coscienza di essere
amati e di avere valore agli occhi del Signore che li aveva invitati
e aveva mangiato, bevuto e conversato con loro. E le loro miserie
e difficoltà diventavano paradossalmente una messa in evidenza del
suo amore, una sottolineatura della sua amicizia. Per loro, affermare
che il Signore era un amico, la persona più cara al mondo, era un’evidenza
e un’esperienza permanente del cuore che non trovava, né in loro
stessi né negli altri, alcuna possibilità di contestazione o di dubbio.
La missione evangelizzatrice della Chiesa passa attraverso delle
persone così, delle persone la cui gioia è il rapporto personale
con Cristo. Poco importa allora se sono miseri e peccatori, come
Zaccheo, come la Samaritana, o come gli stessi Apostoli. L’importante
non è di essere soggetti migliori, ma soggetti toccati dall’amicizia
con Cristo, soggetti che, per riprendere una frase di san Benedetto
cara al Papa, cercano di «non preferire nulla all’amore di Cristo»
(Regola 4,21), cioè persone per le quali l’amicizia di Gesù
è tutto. San Pietro ha rinnegato Gesù, ma nemmeno per un istante
il suo cuore ha potuto disprezzare l’amicizia di Cristo.
Oggi, Pietro ci ha parlato di nuovo e in fondo non ha fatto che riecheggiare
l’unica esigenza che il Risorto gli ha posto per essere un pastore
degno di Lui e fecondo per l’umanità: «Simone di Giovanni, mi ami
tu?» (Gv 21,15).
La preghiera è il desiderio di rispondere sempre di «sì» a questa
domanda del Signore. |